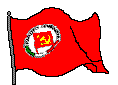|
Una
premessa politica
Da un
pezzo, nel nostro paese, Karl Marx non è più “di moda”.
In altri luoghi del mondo – nelle Università degli Stati
uniti d’America, per esempio – lo si legge e lo si
studia, come un punto di riferimento e di confronto
ineludibile, rispetto all’analisi dei processi sociali.
In Francia, a Parigi, si continua ad organizzare ogni
anno un convegno di aggiornamento marxiano, al quale
partecipano intellettuali di rango di tutte le
provienienze, e di molte scuole. In Italia non è così, e
per ragioni che hanno prima di tutto a che fare con il
travaglio politico della sinistra moderata, avviato
negli anni ’80, culminato nello scioglimento del Pci,
proseguito nelle difficoltà – a tutt’oggi irrisolte –
di dar vita ad un nuovo soggetto riformista. Nell’ansia
di “modernizzazione”, ma anche di nuova legittimazione
occidentale, che ha caratterizzato gli ultimi due
decenni, il marxismo è stato così derubricato alla
condizione di “dottrina obsoleta”, sostanzialmente
ottocentesca e non più utile alla comprensione del
capitalismo del XXIesimo secolo. Un processo avallato
non solo dalla destra, ma, appunto, anche dalla parte
maggioritaria dell’intellettualità di sinistra (almeno
quella che “fa opinione” ed ha presenza mediatica). Una
rimozione che, dall’89 in poi, è apparsa confermata dai
fatti: il tragico fallimento del cosiddetto socialismo
reale, prima, e l’insorgere di quella “nuova rivoluzione
capitalistica”, che si può diversamente nominare e
analizzare, ma che in ogni caso ha aperto, su scala
mondiale, un nuovo ciclo dell’economia e della
produzione. Il capitalismo neoliberista, apparso così
trionfante da aver prodotto, alla fine del secolo
scorso, l’ideologia del pensiero unico.
Eppure, proprio all’alba del XXI secolo la rinascita
dei movimenti – in Italia da Genova 2001 in poi – ha
spezzato questo clima, mettendo in radicale discussione
proprio la fiducia nel sistema e nella sua pretesa di
rappresentare l’approdo “definitivo” dell’umanità. E’
ben vero che la protesta altermondialista non ha
prodotto la riscoperta di Marx (o la rilettura
collettiva dei classici del movimento operaio), com’era
avvenuto nel ’68 e, sia pure in termini molto più
parziali, alla fine degli anni ’70. E che essa si è
presentata sulla scena del mondo in netta soluzione di
continuità con il passato – comprese le ideologie legate
alla storia del ‘900 e del movimento operaio. Ma è vero
anche, se non soprattutto, che essa ha assunto,
rielaborandolo in forme del tutto autonome e originali,
quel “deposito” di cultura critica, di antagonismo, di
anticapitalismo, che il movimento operaio ha disseminato
per quasi due secoli. Quell’humus, quell’onda lunga,
quel patrimonio pur oggi spesso sommerso e disperso di
soggettività altra che nessuna sconfitta ha potuto
cancellare dalla scena della storia. E dunque? Dunque,
anche se i giovani alternativi di Porto Alegre, i dalit
di Mombay, i pacifisti senza se e senza ma di tutto il
pianeta non sono corsi a rileggere testi come il
“Capitale” o “Il Manifesto”, sono proprio loro che
hanno ricominciato a (ri)scriverli.
Tornare a Marx: perché?
Proprio
questo esplosivo avvio del XXI secolo, dove la
catastrofe convive con nuove possibilità di liberazione
umana, conferma la nostra più antica persuasione: Karl
Marx non è, nient’affatto, un “cane morto”. Anzi, a
dispetto di tutte le mode e di tante cecità, è
essenziale “ritornare a Marx” per riscoprirne la
fecondità. Ovvero, il “marxismo di Marx” - ben di più
dei numerosi “marxismi” che si sono succeduti nel secolo
scorso – a noi pare vivo e attuale: il marxismo non
certo inteso come un sistema di verità o di dogmi (sulle
quali sarebbe comunque calato oltre un secolo e mezzo di
enormi mutazioni sociali e politiche), ma come strumento
di lettura delle contraddizioni fondamentali del
capitalismo del nostro tempo. Non stiamo riferendoci,
ancorché su basi “filologicamente” fondate, solo alla
categoria della capacità di previsione: il Marx
profetico, insomma, il Marx che è stato capace di
cogliere lo sviluppo estremo della logica del capitale,
molti decenni prima che questa logica divenisse visibile
o, addirittura, si dispiegasse in termini clamorosi (la
globalizzazione capitalistica), non è ancora il Marx
politico di cui avvertiamo la necessità. Perché allora
ha senso questo “ritorno”?
Forse, la risposta piu’ persuasiva è anche la piu’
“semplice”: si puo’ (si deve) tornare a Marx perché la
sua elaborazione teorico-politica costituisce il punto
piu’ alto della critica dell’economia politica. E la
critica dell’economia politica, cioè del capitalismo, è
precisamente il lavoro rivoluzionario che spetta al
nostro tempo: se è vero, come a noi pare vero, che
questo modo di produzione è oggi incapace di coniugare
progresso (l’incredibile progresso scientifico e
tecnologico di questi anni) e benessere sociale. E’
“modernizzazione senza modernità”. E’ di nuovo guerra –
guerra come dottrina “preventiva” e pratica strategica
permanente e infinita, che si sostituisce alla politica
e alimenta\viene alimentata dal suo “fratello gemello”,
il terrorismo. Il mondo di oggi è più vicino alla
barbarie di quanto forse non sia mai stato nella storia
recente: ecco perché nessuna sinistra degna di questo
nome può prescindere dalla lezione di Marx. Come egli
ebbe a scrivere, il capitalismo rappresenta sì per
l’umanità l’”uscita dalla preistoria” – ma la “storia”
reale potrà cominciare, potrà essere scritta, soltanto
alla condizione di andare oltre la logica del sistema,
lo sfruttamento del lavoro e l’alienazione umana. In
questo senso, il pensiero di Marx resta la teoria piu’
radicale - ispirata alla categoria massima della
politica, che è la rottura rivoluzionaria, secondo
Franco Rodano - che il movimento operaio abbia saputo
esprimere nella sua storia piu’ che secolare.
“La storia di ogni società esistita fino a
questo momento...”
Rispetto alla radicalità politica della Critica del
Programma di Gotha, alla potenza disvelatrice della
Questione ebraica, alla straordinaria modernità (ipermodernità)
dei Grundrisse, il Manifesto si presenta oggi - si
presentava ieri - come un testo “circoscritto”. Un libro
molto legato al clima delle rivoluzioni del 1848 ed alla
necessità di popolarizzare un programma relativamente
contingente. Eppure, queste 23 pagine a stampa,
catalogabili nel genere della “divulgazione” e della
“propaganda”, hanno acquistato nel tempo lo statuto che
spetta non solo ai grandi classici, ma ai libri
archetipi: quelle opere che hanno esercitato
un’influenza determinante nella storia della civiltà
umana, come la Lettera ai romani di Paolo di Tarso, il
Contratto sociale di Rousseau, L’origine della specie di
Darwin (queste ultime, insieme al Manifesto, ha scritto
lo storico inglese A. N. Wilson, “si ritiene abbiano
cambiato il modo in cui gli uomini guardano a se
stessi”).
Certamente, la forza di questo testo sta soprattutto
nell’analisi, a cominciare dalla potenza sovversiva del
suo incipit: “La storia di ogni società esistita fino a
questo momento è storia di lotte di classi” è una
scoperta teorica di portata gigantesca, espressa con
tale efficacia sintetica da produrre, anche, una delle
frasi piu’ “belle” che siano mai state scritte. In
questo improvvisa, abbagliante Aufklaerung
(Rischiaramento), si fa giustizia di ogni concezione
idealistica, o sociologistica, o spiritualizzante della
storia - tanto è vero che l’intero corpus della ricerca
che andrà, da quel momento in poi, sotto il nome di
“scienze umane”, non potrà non tenerne conto, e non
potrà in nessun caso evitare il confronto con questa
enunciazione. In essa ci sono le ragioni di una nuova
presenza, di un nuovo accesso alla grande scena della
storia: quello del proletariato, non piu’ una classe
subalterna e oppressa tra le classi oppresse e
subalterne, ma la nascita di un nuovo protagonista della
modernità. E c’è la carta di identità di un nuovo
soggetto, attraverso il quale l’immagine dello spettro -
lo spettro del comunismo - di colpo si materializza, si
sostanzia di corposità sociale, si prospetta come una
concreta chance della politica. Essa, in un secolo e
mezzo, ha percorso un lungo e non lineare cammino,
costellato anche di molti esiti tragici. Ma non ha
perduto la sua verità.
Vecchio e nuovo proletariato
Ma può
essere ancora oggi il proletariato – la classe operaia
dell’industria - il soggetto centrale della
trasformazione? Non è nel frattempo intervenuto un
processo di drastica riduzione, anche fisica, dei
lavoratori e degli operai manuali? Non è in crisi,
soprattutto in Italia, ma anche negli altri paesi
avanzati, la grande industria che si “incaricava” di
concentrare e – quasi - di unificare il suo antagonista
operaio? Questi interrrogativi, che corrono da anni nel
dibattito politico e teorico della sinistra, non possono
essere elusi, neppure nel breve spazio di questo scritto
.In prima istanza, è vero, queste domande muovono da una
visione edulcorata delle contraddizioni sociali, da una
vocazione interclassista, talora da un frettoloso e
superficiale “nuovismo”. Non è casuale, del resto, che
tutti i certificati variamente rilasciati di “morte
presunta” di Marx e del marxismo siano sempre stati
organicamente connessi con una dichiarazione parallela
di “morte della classe operaia”, ora nei termini della
sua scomparsa, perfino fisica, ora in quelli, solo un
poco piu’ sfumati, della “fine della centralità
operaia”, ora in quelli, ancora piu’ teorici,
dell’esaurimento della contraddizione - strategica e
strutturale, s’intende, ma anche culturale e civile -
tra capitale e lavoro. Da questo punto di vista, si può
replicare che, sulla scala del mondo, il lavoro operaio
nel senso stretto del termine si è accresciuto, si sta
accrescendo, anche dal punto di vista quantitativo. Non
è ”evaporato”, il fantasma operaio, rispetto al piccolo
“spicchio” di Europa che Marx aveva di fronte a sé
quando scriveva il “Manifesto”: al contrario, dalla
classe operaia della Gran Bretagna, della Francia e
della Germania, siamo passati al ben più esteso
proletariato, anche industriale, del pianeta. Il
fantasma, dunque, resta corposo, anche nella sua
dimensione materiale. L’ideologia ancor oggi molto
accreditata della “fine del lavoro” (così come nei ’60
le tesi sociologiche sull’inevitabile destino di
integrazione della classe operaia) si rivela così
soprattutto un’ideologia – nel senso che Marx spesso usa
di “falsa coscienza”.
In seconda istanza, tuttavia, dobbiamo sapere che queste
obiezioni colgono (sia pur travisandolo) un punto molto
rilevante: il grande mutamento intervenuto nella
composizione sociale e di classe, nella figura del
lavoratore, nella stessa funzione del lavoro. Un
processo in virtù del quale lo sfruttamento
(l’estrazione del plusvalore) non si produce più né
soltanto né prevalentemente all’interno del processo
produttivo, ma si allarga all’insieme della società.
Marx descriverà questa tendenza in alcune celebri pagine
di quella straordinaria mole di appunti preparatori al
“Capitale”, poi conosciuta (e pubblicata solo a metà del
secolo scorso) come “Lineamenti fondamentali (Grundrisse)
della critica dell’economia politica”: da un certo
livello di sviluppo in poi, la logica del capitale
sussume sempre di più “l’uomo stesso” come capitale
fisso e come fonte della ricchezza. Non il singolo
produttore, “non il lavoro immediato eseguito dall’uomo
stesso”, ma la produttività generale del “corpo
sociale” – il patrimonio produttivo di scienza e
conoscenza, lo sfruttamento della natura, il dominio
(“il furto”) crescente del tempo di vita. Una
contraddizione che non può risolversi all’interno della
logica del sistema. Non la vediamo sotto i nostri occhi,
ogni giorno? Non è anche questa la radice dei processi
oggi galoppanti di precarietà e flessibilità, nei quali
la “disponibilità” del lavoratore (del suo tempo)
diventa la chiave di volta dell’economia? E non è questo
che spiega la ragione di quell’apparente “evaporazione”
del fantasma operaio? Da questo punto di vista, il
proletariato del mondo attuale è immenso, infinitamente
più esteso di quello che Marx descriveva nel
“Manifesto”: è composto dalla maggioranza dei
lavoratori, e forse perfino dell’umanità. Ma è un
soggetto frammentato, disperso, non più unificato dalla
“macchina” capitalistica, come accadeva nel ciclo
fordista e taylorista – spesso invisibile a se stesso.
La ricomposizione del nuovo proletariato è dunque il
nostro compito strategico. Il più improbo, e il più
necessario.
La mondializzazione
Proprio
nel Manifesto, Marx preconizza quella sorta di sviluppo
prometeico della borghesia, nonché quei processi di
tendenziale unificazione del mercato mondiale e di
interdipendenza economica internazionale, che, qualche
decennio piu’ tardi, verranno analizzati sotto il nome
di globalizzazione. Vi sono, in questo senso, alcuni
passaggi che mantengono, a un secolo e mezzo di
distanza, un suono profetico: “Il bisogno di uno smercio
sempre piu’ esteso per i suoi prodotti sospinge la
borghesia a percorrere tutto il globo terrestre.
dappertutto deve annidarsi, dappertutto deve costruire
le sue basi, dappertutto deve creare relazioni. Con lo
sfruttamento del mercato mondiale la borghesia ha dato
un’impronta cosmopolitica alla produzione e al consumo
di tutti i paesi. ....Le antichissime industrie
nazionali sono state distrutte e vengono distrutte ogni
giorno...soppiantate da industrie nuove....che non
lavorano piu’ soltanto materie prime del luogo, ma delle
zone piu’ remote...All’antica autosufficienza e
all’antico isolamento locali e nazionali subentra uno
scambio universale, una interdipendenza universale tra
le nazioni”. Ma piu’ in generale, è la funzione
rivoluzionaria della borghesia che viene descritta nella
sua straordinaria potenza nonché nei suoi effetti
devastanti: quella borghesia che “ha affogato nell’acqua
gelida del calcolo egoista i sacri brividi
dell’esaltazione devota, dell’entusiasmo cavalleresco,
della malinconia filistea”; quella borghesia che tutto
riduce a “un puro rapporto di denaro”, compresi i sacri
affetti familiari; quella borghesia che “ha tramutato il
medico, il giurista, il prete, il poeta, l’uomo della
scienza, in salariati ai suoi stipendi”. Non c’è
narrazione piu’ sintetica ed efficace di cio’ che
abbiamo chiamato modernità: la nascita del rapporto di
capitale come condizione di una nuova fase della storia
umana, nel corso della quale “si dissolvono tutti i
rapporti stabili e irrigiditi”, mutano in profondità le
stesse nozioni di tempo e di spazio, muta radicalmente
il rapporto con la tradizione e la formazione delle idee
(“tutte le idee e i concetti nuovi invecchiano prima di
potersi fissare”). In breve: per la prima volta, nei
secoli, l’umanità puo’ pensare di costruire da
protagonista il proprio destino. Gli uomini “sono
finalmente costretti a guardare con occhio disincantato”
a se stessi, alla propria collocazione nel mondo, alle
proprie relazioni - gli uomini in carne ed ossa, divisi
in due classi radicalmente antagoniste, che si
estendono, come tali, al teatro del mondo.
Non c’è, nel Manifesto, alcun limite - concettuale - di
tipo nazionale, locale, provinciale: ecco un altro
tratto distintivo della sua modernità. C’è la
“disponibilità” del pianeta, in quanto tale,
all’espansione del movimento del capitale: ecco il
limite della “profezia” marxiana della globalizzazione,
quale nel libro è prospettata. Giacchè, in un senso
preciso, in questa proiezione del futuro prossimo del
capitalismo Marx applica uno schema seccamente lineare,
che nel corso dei due secoli successivi si è rivelato
assai diverso - anche e soprattutto in virtu’ di quel
meccanismo di dominio internazionale e di blocco dello
sviluppo in una parte consistente del pianeta che si è
chiamato imperialismo. E oggi l’unità apparente del
mondo nasconde la crescita dirompente della divisione
tra Nord e Sud - anzi, tra i molti Nord e i molti Sud
che compongono la nuova geografia mondiale disegnata dai
colpi del neoliberismo: se è dunque lecito parlare di
mondializzazione della produzione, non è lecito in
nessun caso parlare di mondializzazione dei consumi, in
una fase caratterizzata dalla polarizzazione crescente
della ricchezza come della povertà.
In sostanza, ritorna una aporia culturale e politica che
non riguarda principalmente Marx, ma noi, la sinistra
del prossimo millennio. Questa aporia ha al suo centro
la nozione, appunto, di modernità: per circa un secolo e
mezzo, essa è andata di concerto con lo sviluppo della
borghesia, e della lotta di classe che al dominio
borghese è stata opposta, nelle piu’ diverse modalità di
conflitto, di protesta, di vera e propria lotta
politica, fino alle rotture rivoluzionarie e statuali.
Modernità e borghesia sono state, nella sostanza,
coincidenti, e il loro parallelo (e ovviamente anche
dialettico) processo di sviluppo ha quasi sempre
costituito - ri-costituito - un quadro di rapporti, un
equilibrio di base piu’ avanzato - piu’ favorevole,
rispetto al nostro endziel, la meta finale della nostra
lotta, come usava dire Rosa Luxemburg. Oggi, questa
coincidenza va spezzandosi, forse definitivamente. La
globalizzazione produttiva, comunque la si intenda e la
si analizzi, non costituisce un “progresso oggettivo” né
allarga lo scenario possibile della nostra lotta. E la
così detta “III Rivoluzione industriale” tende a
inghiottire la modernità nei flutti di una autentica
regressione sociale, politica, civile. Questa realtà ci
costringe a fare i conti, ben piu’ di quanto il
movimento operaio non abbia mai fatto, con la “logica
della dinamica storica”, con l’idea di “leggi della
storia” che, pur estranee a Marx, non sono certo state
estranee a decenni di marxismo.
Marx profeta negativo?
Appunto, torniamo a Marx: “...lotta che ogni volta è
finita o con una trasformazione rivoluzionaria di tutta
la società o con la comune rovina delle classi in
lotta”. In questo passaggio, che si trova proprio agli
inizi del Manifesto, Marx enuncia in termini sintetici
ma inequivocabili la possibilità della sconfitta -
sconfitta che, se ci sarà, non sarà solo di una classe,
del proletariato, ma dell’intera società moderna.
Eppure, nella storia successiva e nella vulgata
marxista, ha prevalso una “filosofia della storia”,
spesso in forma di vera e propria scolastica: essa,
attraverso la sequenza dei diversi modi di produzione
(antico, asiatico, feudale e borghese) che si succedono
nella storia, ha prefigurato un’idea di progresso
lineare che non potrà che esser coronato dal socialismo
e dalla vittoria del proletariato. Un’idea
sostanzialmente estranea a Marx (compreso il celebre
schizzo di autobiografia intellettuale contenuto nella
Prefazione a Per la critica dell’economia politica), ma,
invece, fortemente radicata nel socialismo della II
Internazionale prima, nell’esperienza della III
Internazionale poi. Una caduta di segno positivistico e
scientista, che ha alimentato altresì quella cultura
industrialistica e “sviluppistica” - ispirata in
sostanza dalla bontà, comunque, della crescita
quantitativa - che tanti ritardi ha prodotto anche a
sinistra, in particolare nel rapporto con le istanze
ambientaliste e nel confronto con la nozione stessa di
“limite”.
Invece, nella partita della “fine della preistoria” e
dell’”avvento della storia”, bisogna prevedere anche la
possibilità della sconfitta. Il socialismo non è un
approdo necessitato della storia: è l’unica chance,
certo, di salvezza, non solo per le classi oppresse, ma
per la civiltà detta moderna. Ma è soprattutto l’esito
possibile di una lunga lotta rivoluzionaria, che, per
vincere, non puo’ dunque affidarsi né ad attese
messianiche né alla catastrofe spontanea, lo
Zusammenbruch, del sistema capitalistico, né
all’”oggettivo dispiegamento” delle contraddizioni
sociali, politiche o interstatuali (produttrici, queste
ultime, di guerre prima che di rivoluzioni). Si radica
qui un’idea della trasformazione che non puo’ che essere
radicale: il socialismo non puo’ “ereditare” lo sviluppo
economico, così come esso è stato determinato e
orientato dal moderno movimento del capitale, per
gestirlo politicamente con altre modalità; il
socialismo, altresì, non può scaturire da una
progressione delle coscienze, da una organizzazione
della soggettività, che asseconda la spontaneità sociale
e la indirizza verso altri fini e interessi. In breve:
il socialismo - la possibilità che ci è ancora ci è data
di evitare la “comune rovina delle classi in lotta” -
non è un mutamento, piu’ o meno traumatico, di classi
dirigenti, ma un progetto di costruzione di un altro
sviluppo, di un’altra modalità di organizzazione
dell’economia, di un’altra configurazione delle
relazioni tra gli individui, i sessi, le persone, i
popoli.
E proprio l’avvertenza di Marx si propone oggi per uno
straordinario confronto con i processi attuali. Non
parliamo, naturalmente, delle sconfitte che il movimento
operaio e i comunisti hanno subito in questo secolo e
mezzo, e in specie alla fine dell’ultimo. L’attualità
dell’ipotesi di sconfitta - non sembri un paradosso -
sta principalmente nella dinamica attuale del
capitalismo: se, nel corso del XX secolo, esso ha
rovesciato le sue contraddizioni addosso al mondo nella
forma della guerra planetaria e della minaccia della
catastrofe nucleare, esso, alle soglie del XXI, esprime
le sue pulsioni distruttive nella forma privilegiata
della devastazione sociale di massa - strage di popoli,
distruzione del lavoro, disoccupazione strutturale e
ipersfruttamento. Il neoliberismo, da questo punto di
vista, non è un incidente di percorso, e non è neppure
la provvisoria rinuncia, per assenza di margini
“oggettivi”, a politiche di tipo riformista: è la
manifestazione storica dei limiti strategici raggiunti
dal capitalismo, cioè di quella rottura tra crescita
economica e modernità che “fatalmente” deriva dalla
riduzione dei rapporti umani a rapporto di danaro, alle
“gelide acque del calcolo egoista”. Per la prima volta
da molti decenni a questa parte, la modernizzazione si
sviluppa versus la modernità, non insieme ad essa:
straordinariamente indicativa, in proposito, è
l’aggressività della campagna politica e culturale
contro la libertà delle donne, portata avanti dalle
gerarchie ecclesiastiche (ma non solo) in una logica
restaurativa del dominio patriarcale e sessista. In
realtà, la “rivoluzione femminile” in atto non può che
scontrarsi – per usare una terminologia marxiana – con
gli attuali rapporti di produzione: proprio poiché
tende ad oltrepassarli, viene fatta oggetto di un’ondata
regressiva, “premoderna”, oscurantista. Ma non è questo
un limite storico della logica del capitale?
Conclusione
Il
Manifesto non è soltanto il piu’ bel testo politico che
sia mai stato scritto: è un libro essenziale da (e per)
traghettare nel XXI secolo. Il suo celebre motto
conclusivo, Proletari di tutti i paesi, unitevi!,
mantiene intatta la sua forza ben al di là della
suggestione emotiva e storico-simbolica che pure
legittimamente continua a suscitare. Esso ha alluso
ieri, e continua ad alludere per il prossimo futuro,
alla sfida decisiva nella quale la sinistra antagonista
deve cimentarsi: la costruzione del nuovo soggetto della
trasformazione anticapitalista, la ricomposizione di
classe, la comunicazione attiva dei diversi soggetti che
potranno concorrere all’alternativa antiliberista. Come
ieri, ancor piu’ oggi e domani, il luogo di questa lotta
è la platea del mondo. Un mondo, appunto, tutto da
guadagnare. Ancora.
|